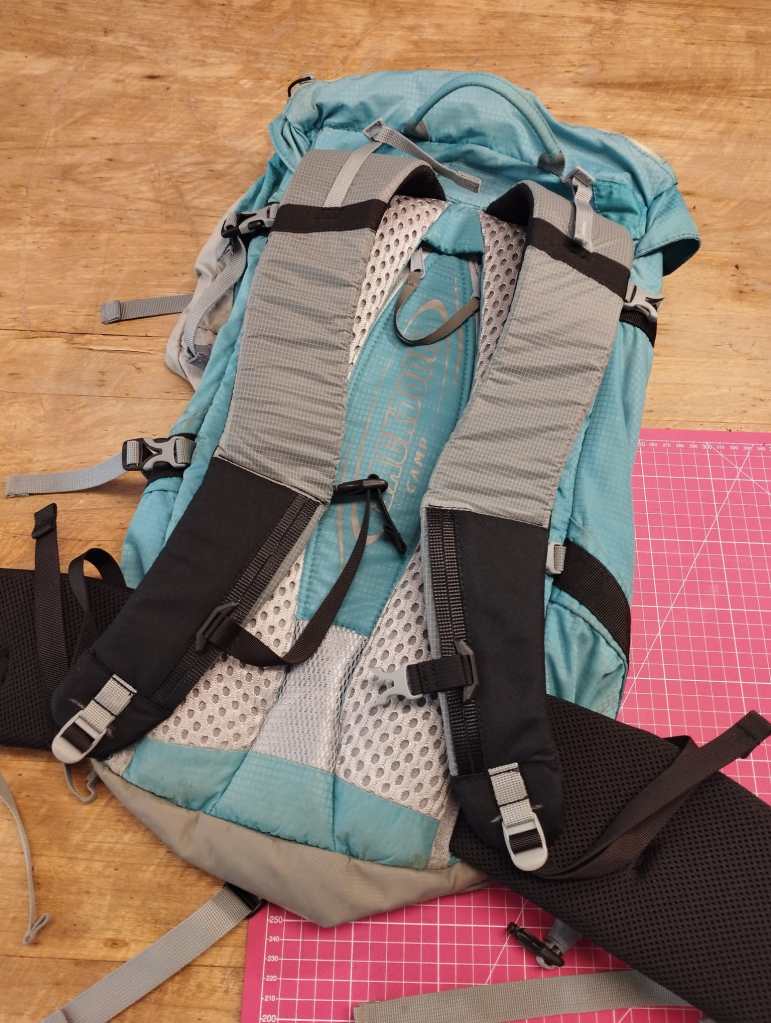di Saverio D’Eredità
Io sullo Stenar volevo dire una cosa o due al massimo. Che ovviamente è una montagna molto bella e se vista dal Triglav molto elegante e anche il Triglav visto dallo Stenar è meraviglioso e quindi mi immagino i due, Stenar e Triglav, che ogni mattina si fanno i complimenti l’un l’altro di quanto stanno bene. Che lo Stenar è anche una delle pochissime cime delle Giulie che puoi partirci con gli sci diretto dalla cima, almeno per noi sciatori senza qualità e fantasia, e che sembra fatto apposta quel pendio che ogni curva fai un inchino al Triglav.

Volevo dire una cosa, ma anche due in effetti, sullo Stenar, che ogni volta che ci penso o me lo chiedono, metto una faccia tipo vecchio lupo di mare che ha cacciato nelle baleniere giapponesi e dice “Ah, lo Stenar” tipo “ah! Il mare di Barents!” perché con lo Stenar c’ho avuto delle storie complicate. Di quella volta che sono salito a giugno che pareva marzo e la neve in vita e un freddo cane (quindi sarebbe un’invernale, di fatto). O di quando poco sotto la cima ci siamo fermati un momento a metter su la giacca che tirava vento e il Batti si è girato a pisciare e un colpo di vento lo ha prima messo in ginocchio e poi sbattuto per terra con la faccia nella neve e il coso pure. E un secondo dopo è arrivata una nube nera tipo Mordor e ci siamo rintanati in una dolina che sta proprio alla fine del traverso prima della cima. La nube ci ha letteralmente inghiottiti per mezzora, tanto che a un certo punto ci siamo detti e “mo che cazzo facciamo”.
Che lo Stenar quella volta, quella dopo Mordor e il Batti a faccia in giù, siamo scappati giù per la Sovatna e il vallone era una ghisa mortale e io la ghisa (ghisa: dicesi di neve talmente dura da non essere scalfibile manco dalla fresa) non la so sciare e allora a metà vallone ho fatto un numero da equilibrista per togliere gli sci mettere i ramponi e non perdere nulla – da quella volta lo Stenar è tipo un archetipo della gita sfigata, nel nostro immaginario.
Che lo Stenar, un’altra volta, c’era una nebbia, ma una nebbia, di quelle che ti ribalti da solo da fermo. E quindi in cima che ci andiamo a fare.

Insomma, sullo Stenar altro che due cose: mille ce ne sarebbero, ma ne voglio dire una. Che però riguarda anche tante altre montagne delle Giulie e slovene in primis che ovviamente sono superiori a tutte le altre (del mondo, che discorsi) perché a un certo punto basta con questi giudizi ponderati, basta moderazione e un sano arrogantissimo localismo mi fa bene, specie ora che si apre la stagione del “si potrebbe andare 3 giorni a…” e non si fa nulla anche quest’anno.
E quindi, vi dico, dove le trovate montagne dove potete sciare tutti e dico tutti i tipi di neve possibile? Si, non dico in un giorno con gli impianti, ma proprio sullo stesso monte! Che c’abbiamo avuto la neve arata, la neve arata, ma senza fondo, la neve cartonata e al tempo stesso ventata portante (nello stesso raggio di curva intendo), e poi la pistata e poi ancora la farina pesante e quella meno pesante. Poi la trasformata (2 o 3 secondi mi pare) e il firn (un momento proprio). E poi il cemento “sablè” diciamo (accogliamo quindi la neve sabbiata nel nostro gergo, ci darà tante gioie nel futuro mondo climaticamente impazzito che non avete idea), che è insciabile secondo me. E poi la polvere. Polvere vera, altro che gennaio, polvere per 100, 150 metri che stai già pensando come alzare la cresta poi con gli amici e invece – sbam! – crosta. Crosta portante. Indefinito. Indefinito portante un po’indurito. Gesso. Gesso mollato. Pappetta. Caffè shakerato (non ve l’aspettavate eh?) che è diverso da granita al caffè immediatamente successiva (il caffè è la sabbia di cui sopra inumidita). Poi panna. Panna con mugo sotto a rischio risucchio. Bagnata. Ghiaione.
Ecco, io volevo giusto dire una cosa sullo Stenar, ma in generale sulle montagne, queste montagne. Che quando torni giù (dove lo trovi un bosco di faggi centenari ti accompagna al prato dell’Aljazev dom, in un turbinio di neve che pare polistirolo?) con sci in spalla, scarponi pure e pantaloni arrotolati sotto al ginocchio ti sembra di portare un mondo intero sulle spalle. Vite intere. Universi interi. Che tutte quelle curve diverse, il cambiare assetto e posture e sguardi sono tutte un allenamento alla vita. Al non darsi per scontati ed essere preparati. A non aspettarsi niente e lasciarsi sorprendere da tutto e ad ogni istante. Questo andrebbe insegnato, questo andrebbe tramandato. Bisognerebbe sciare anche solo per questo. Per realizzare che non andiamo lì per prendere qualcosa, per consumare qualcosa. Ma per guadagnare qualcosa, per imparare qualcosa. Questo volevo dire, ora, mentre mi accorgo dopo anni che tutto sommato sto sentiero non è nemmeno così infame e io non so nemmeno così stanco. Cioè che mettendo da parte la perfezione, se si rinuncia alla perfezione (di una montagna, della neve, delle condizioni o della prestazione: traducete pure tutto questo nelle cose di ogni giorno), paradossalmente alla perfezione ci si avvicina di più. Alla completezza dell’esperienza. Che è ciò, in definitiva, che più conta.
Una o due cose volevo dire e invece, scusate, ne ho trovate mille.
Stenar mt.2501
Montagna elegante che fronteggia sul lato destro della Vrata, l’immensa muraglia del Triglav. Certamente il suo maggior pregio è la vista che spazia dalle Caravanche alla Val Trenta, dal Triglav al Razor. Inoltre, è meta scialpinistica di pregio, se non altro perchè tra le cime maggiori delle Giulie tra le poche sciabili direttamente dalla sommità. Due i percorsi possibili, entrambi dall’Alijazev Dom, eventualmente anche ad anello.
Da Nord-Est
Si prende dalla spianata antistante il rifugio il sentiero per Bivak 4 e Skrlatica. Risalire un fitto bosco di faggi sempre piuttosto ripido (normalmente poco sciabile o non sciabile per mancanza di neve a primavera), fin sotto una fascia rocciosa che si aggira a sinistra salendo poi per larici e mughete ad un ampio pendio sotto la notevole parete nord est. Si piega prima a destra poi, sotto una fascia rocciosa, a sinistra entrando nell’evidente vallone che conduce alla Stenarska Vratica, selletta tra Stenar e Kriz. Gli ultimi 50 metri sono più ripidi (45°). Dalla selletta traversare a sinistra prima in orizzontale poi in leggera salita ad una spalla, contraddistinta da una profonda dolina. Liberamente per ampio pendio di moderata pendenza (max 35°) in vetta (ore 4).
Da Sud ovest
Dall’Alijazev Dom si prosegue lungo il fondovalle (direzione Triglav/Luknja) e a un bivio segnalato (Pogacnikov Dom) si sale per una faggetta sulla destra. Usciti in campo aperto (resti di valanghe) si risale il largo e ripido vallone di Sovatna, fiancheggiati dalle pareti del Bovksi Gamsovec e del Pihavec a sx e dello Stenar a destra. In cima al vallone si accede all’affascinante altipiano del Kriski Podi. Si percorre in falso piano l’ampia insellatura verso ovest, quindi, in vista della pala sommitale si piega a destra salendo in direzione della Stenarska Vratica dove ci si ricongiunge all’itinerario da Nord Est e quindi in cima (stesso tempo)
Per entrambi gli itinerari il dislivello è 1500 metri.
Difficoltà: 3.3/E2