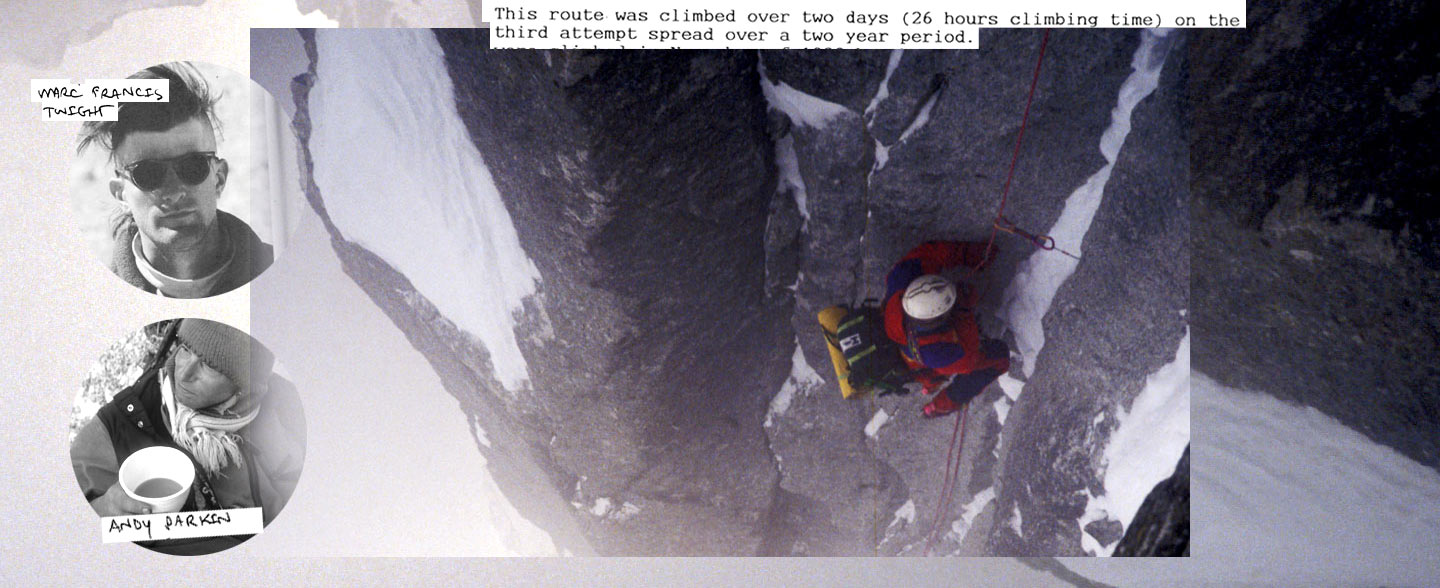di Saverio D’Eredità
Si dice che l’avventura inizi sempre “un po’più in là”, oltre quella che un termine piuttosto abusato e dal sapore di marketing chiama la “zona di comfort.” Sinceramente non ho mai capito cosa sia questa zona di comfort né ho speso del tempo a definirla. Se dovessi proprio rifletterci, dovrei dire che ci sono situazioni piuttosto comuni (tipo passeggiare in un centro commerciale o cercare l’auto nei parcheggi sotterranei) in cui sento di trovarmi ben al di là della mia “zona di comfort”. Però è un po’triste come cosa, per farne un’avventura.
Il tubo del Gasex spunta dalla neve come il boccaglio di un sub dall’acqua e passandoci vicino mi chiedo se sono ancora nei margini della mia zona di comfort, su questo pendio circondato da impalcature, seggiovie e con l’“unz-unz” di sottofondo che sale dagli altoparlanti degli impianti. A giudicare dal numero di volte che mi fermo per valutare la pendenza dovrei ammettere che non è esattamente così. Strano monte, eh, il Forato. Come tante cime del Canin non brilla per eleganza o bellezza, con quella sua forma a parallelepipedo e le forme ingombranti. Pare un lavoro lasciato a metà o un rudere dimenticato. Come tante cime del Canin, però, offre angolazioni stupefacenti dalle quali appare affilato e persino leggero. Una bellezza sempre un po’controversa, quella del Canin, dove è la somma delle parti, più che il singolo scorcio, a fare impressione. Soprattutto quando l’inverno qui si fa paziente artigiano, operando stucchi e decorazioni, rendendo le anonime stratificazioni e i profili spigolosi incredibilmente vari, affascinanti e misteriosi.

In tutto questo, però, il povero Forato se la passa sempre un po’ male, quasi si fossero messi d’impegno ad imbruttirlo. Grovigli di cavi, piloni, sbancamenti circondano e avviluppano ogni versante. Dimenticavo, in cima c’è anche uno strano bussolotto che sembra una stazione lunare e qua e là se ci fai caso spuntano vecchi ferri ritorti della guerra e fili spinati. Non si direbbe proprio una montagna dove vivere grandi avventure. Eppure, non c’è una volta delle tante in cui ci sono salito che non mi sia trovato, anche solo per una breve parentesi, a passare quella soglia che divide l’abitudinario dall’ignoto. Come ad esempio sulla curva del Gasex. Bisogna ammettere che se non ci fosse questo brutto tubo di metallo, la pala est del Forato passerebbe quasi inosservata. Non così lunga da fare veramente impressione e non così ripida da solleticare sciatori di livello. Eppure quel tubo, piantato lì in mezzo, pare star lì apposta per disegnarci una curva attorno. A segnare il confine dell’avventura a pochi passi dal mondo conosciuto.

Da bambino mi spaventava il blu profondo del mare. Dalla spiaggia di ciottoli potevo vedere le varie gradazioni di azzurro scurirsi via via da quello più chiaro e trasparente della riva, fino al nero del mare alto. Ad una distanza che non riuscivo mai a stimare, emergeva dalle acque una strana struttura, una specie ragno di cemento e acciaio a quattro zampe corroso dalla salsedine e dal vento. Mi sembrava che il mare lì fosse più cattivo e nero. Persino più lontano. Ma forse era proprio quello strano scheletro tappezzato di alghe e mitili, a farmi paura. A dare una dimensione alla profondità del mare. Ogni volta che arrivavo lì, deciso a nuotare nel mare nero, succedeva qualcosa che mi ricacciava indietro. Un giorno, infine, decisi di passarci attraverso. Potevo aggirarlo o nuotare in un’altra direzione, è vero, ma il mare alto, il mare nero, iniziava lì. Per farmi forza presi a battere forte i piedi ed infine mi immersi a pelo d’acqua, cercando di contrastare la corrente. Appena sotto la superfice l’acqua era calma e ferma. Piccoli pesci brucavano le alghe appese al palo di cemento e tutto era silenzio. Riemersi appena oltre, nel mare alto e nero, oltre il confine della paura e di un tempo che mi parve infinito. La riva chiassosa di mamme e bambini non era che a poche bracciate da lì.
Inforco gli sci sulla lunga dorsale della cima e mi avvicino al bordo. Attraverso le punte, posso vedere il profilo del gasex e intuire l’inclinazione del pendio, come quel ragno di cemento mi dava la profondità del mare. Come quella volta, devo passarci attraverso. Se dovessi pensare alle altre volte che sono sceso di qua, alla neve cotta a puntino e al fatto che – in fin dei conti – non sono che poche curve dovrei sentirmi all’interno della mia zona di comfort. Anche meglio di un parcheggio sotterraneo. Eppure la curva del gasex riesce a smontare una ad una le mie certezze, i precedenti e il senso di controllo. Non sto più contando le volte in cui questa scena si è già ripetuta, né ricordando come avevo fatto la prima curva l’ultima volta, che traiettoria avevo preso o se posso distinguere le voci degli sciatori, l’unz-unz degli altoparlanti e l’odore di fritto. L’avventura è come un varco aperto d’improvviso in un mondo parallelo. Puoi decidere di entrarci o meno, e con quali regole. Soprattutto, l’avventura inizia nel momento in cui le nostre certezze vengono meno e affiorano le domande più elementari. Quando iniziamo a dare un valore alle cose. Quando tutto è di nuovo in discussione. E ci riappropriamo di una parte di noi.